Orientarsi
Linguetta #156 / Ogni specie vivente cerca di orientarsi per capire dove andare, così come fanno le parole che usiamo: sono punti di riferimento e mappe da condividere.

Ehilà, eccomi con una nuova Linguetta!
Nei giorni scorsi sono stato ospite al DiParola Festival a L’Aquila e stavo in un albergo: ecco, ogni volta che uscivo dalla porta della camera, andavo istintivamente a sinistra, accorgendomi poi che le scale erano dall’altra parte del corridoio, e via col dietro-front.
Mi muovevo di là perché seguivo la posizione della maniglia, come fosse una freccia.
Gli ambienti attorno a noi ci orientano.
E lo stesso fanno le abitudini a stare in luoghi che conosciamo: ci suggeriscono implicitamente come e dove muoverci, perché la nostra testa, nel tempo, ha disegnato al suo interno risposte e azioni precise per quello che processa fuori da sé.
Un po’ quello che succede a tassiste e tassisti di Londra, che devono muoversi ogni giorno fra 25.000 strade e stradine, riuscendo a ricordarne ogni dettaglio dentro il loro ippocampo, cioè la parte del cervello legata alla memoria spaziale1.
Ogni volta che il cervello impara qualcosa, la sua struttura cambia un po’. Come se riuscissimo a orientarci meglio, a costruirci una mappa di viaggio più dettagliata.
Punti di ritrovo
Quando non c’erano sistemi di intelligenza artificiale tascabile che estraggono dati per dirci in che quadrante terrestre ci troviamo, allora facevamo due cose per strada: provavamo e chiedevamo.
Ma pure adesso, che tentativi e richieste sono a portata di polpastrello (o comando vocale), arrivare in un posto nuovo sconvolge ancora il nostro senso d’orientamento.
Ci serve tradurre le mappe mentali in appigli visivi nella realtà che ci circonda, così come capita con un linguaggio nuovo, e come capita ogni volta che perlustriamo un ambiente fatto di parole.
Anche dentro un testo ci serve un orientamento.
La lingua usata in maniera precisa è un GPS su cui possiamo contare, ci dà coordinate e perimetri di movimento; e lo fa ad esempio anche quando sta nei cartelli che possiamo incontrare in strade, musei, biblioteche, uffici, boschi, spiagge, impianti industriali, mezzi pubblici.
Ogni cartello porta un messaggio, che ci comunica qualcosa e ci aiuta a completare un’azione.
Camminare per una città nuova è un esercizio di lettura continuo.
Senza segnali né guide, non capiamo che cosa fare, come è capitato a me, sempre nel viaggio verso L’Aquila, dovendo prendere il bus da Roma Tiburtina e trovandomi di fronte a una coperta patchwork di cartelli e volantini appiccicati sui vetri delle biglietterie.
Il senso di disorientamento è attrito comunicativo, mentre parole e spazi progettati bene (senza affollamenti e con chiare indicazioni) ci aiutano a distendere il pensiero e vivere meglio.
Origini in movimento
Quando un pettirosso lascia le foreste sempreverdi della Scandinavia per fuggire dall’inverno andando a sud, in un punto del Mediterraneo, inizia a muoversi seguendo la sua mappa celeste interna.
E come tante altre specie di animali non umani, il pettirosso si orienta seguendo direzione e intensità del campo magnetico terrestre.
L’orientamento è questione spaziale.
Orientarsi ha a che fare con oriente, che deriva dal verbo oriri, cioè sorgere. Ecco, sorgiamo in un punto e poi ci spostiamo.
Come il pettirosso, oppure i salmoni, le farfalle monarca, le tartarughe verdi, la sterna artica, anche noi umani migriamo. Di continuo.
La stessa cosa che succede alle parole, che migrano da un sistema linguistico all’altro, e ci aiutano a orientarci.
Sono l’equivalente delle montagne o della linea d’orizzonte del mare: punti di riferimento, senza cui ad esempio io mi sentirei perso.
La lingua ci orienta, è la nostra bussola.
Le parole servono soprattutto a riorientarci, a rimuoverci dal nostro ambiente per farci guardare da fuori, e vederci meglio; e servono perché le usiamo come guide, perché ogni persona che condivide un ambiente non rimanga disorientata.
Allora orientarsi è una forma di sintonia, di empatia.
Una volta, in un incontro con una classe delle elementari, un bambino mi ha detto:
Qual è stato il primo libro del mondo?
E chi l’ha scritto?
Io credo di avergli risposto:
Il primo libro del mondo raccontava di sogni e visioni.
L’hanno scritto degli umani sulle pareti di una grotta.
Ci siamo mossə da quel punto di origine del linguaggio, e ci muoviamo ancora, superando con gli alfabeti le barriere di spazio e tempo, in un orientamento senza fine.
P.S.
Sono tornato a casa dopo due giorni entusiasmanti al DiParola Festival, l’evento sul linguaggio chiaro inclusivo accessibile che ha reso ancora più chiaro come le parole siano spazi di possibilità per fare incontrare le persone. Lo racconterò in una puntata speciale di Linguetta.
P.P.S.
Chiudo con un’appendice alle mini Linguette di agosto, tornando alla puntata Verso, che le aveva inaugurate con il concorso estivo delle Isoleombra.
Sul profilo Instagram di Sabìr editore c’è un bel post che annuncia chi ha vinto, ma ve lo dico anche qui dentro Linguetta, lasciandovi l’audio (letto da me) del componimento che “a insindacabile giudizio della giuria” è riuscito a descrivere meglio la misteriosa isola della copertina dell’Arcipelago delle isoleombra: ecco L’isola di Lumen di Giusi Pennisi!
🖊️ Inversi
Oggi pochi versi dalla raccolta Exfanzia di Valerio Magrelli.
Una eccezione alla regola
La verità è come il sangue:
ci permette di vivere,
ma non dovrebbe mai venire alla luce.
📚 Rotte nascoste
Il consiglio è per il libro a figure di divulgazione Migrazioni. Gli incredibili viaggi degli animali, scritto da Mike Unwin e illustrato da Jenni Desmond (traduzione di Lucia Feoli): venti storie di animali in movimento e di migrazioni che ne orientano le vite.
🎥 Misteriose pupille
S’intitola I Origins il film di Mike Cahill, in cui l’occhio umano orienta la storia di un biologo molecolare nell’imprevedibile scoperta che unisce prove scientifiche e domande trascendentali. Si può vedere a noleggio su Prime Video.
🎵 Rock sovietico
Grazie a Valentina Di Michele ed
ho scoperto i Kino, che mi hanno tenuto compagnia nel treno notturno di ritorno dall’Aquila a Brescia. Non conosco le parole perché sono in russo, mi ci perdo e mi oriento dentro al ritmo di questi pezzi, ed è bello questo disorientamento. Ve ne linko uno che mi è rimasto dentro:Mi sa che è tutto, noi ci leggiamo alla prossima Linguetta!
Cerchiamo sempre di usare parole che orientino tutte le persone, che in fondo basta usare il 💖, lo stesso cuore che sta qui sotto e che potete pigiare per dirmi se v’è piaciuta la puntata.
Per lasciare un commento c’è lo spazio lì accanto, ma vi aspetto pure via mail, oppure dentro le Notes con un restack della puntata (cioè pigiando la rotellina con le due frecce accanto al simbolo dei commenti).
Se volete taggarmi su Instagram, cercatemi come andrjet. E se volete sono pure su Threads.
Uno studio dello University College London evidenziò che l’ippocampo posteriore di tassisti e tassiste londinesi era più ampio di quello delle altre persone di Londra, proprio perché per guidare un cab (taxi) londinese bisogna superare un test che richiede tre anni di studio e si chiama The Knowledge (La conoscenza).
👉 Vi lascio da leggere due pezzi (+1) che ne parlano:
La conoscenza ingrossa il cervello di
;Ricordi spaziali a cura di Scientificast;
Per chi legge in inglese un pezzo che racconta una ricerca sull’Alzheimer avviata nel 2022 sempre dallo University College London su tassisti e tassiste londinesi.









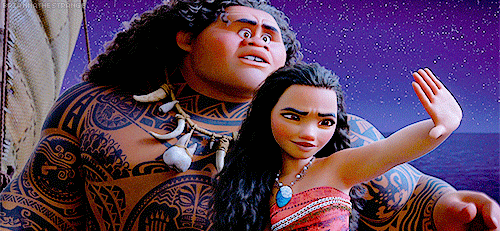

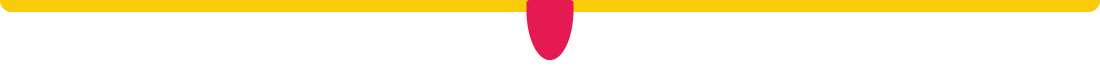




Hai scelto proprio una delle canzoni più incisive, "una stella di nome Sole" ♥ onoratissima di averti conosciuto e di aver passato un po' di tempo insieme, Andrea! Grazie per tutto e alla prossima
Andrea, che bello vederti e sentirti parlare di parole per bambini (quasi come me, i bambini dico) a L’Aquila ☺️
La prossima volta mi faccio coraggio e vengo anche a dirti ciao 👋🏻