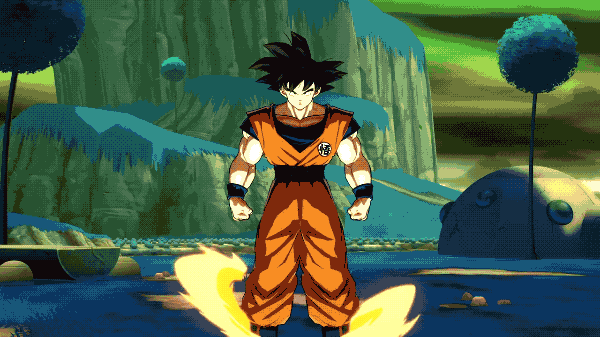Lasciare spazio
Linguetta #56 / Riuscire a fare un passo indietro significa annullare il proprio privilegio, ascoltando la voce di chi non ha mai potuto esprimersi, definirsi e raccontare il mondo.

Ehilà, eccomi con una nuova Linguetta!
Nell’ultima puntata di Colonne — la newsletter su Milano a cura del Post — si parla della pista ciclabile sul ponte della Ghisolfa, che il comune di Milano dovrebbe realizzare insieme a tante altre per rendere la città sempre più a misura di pedale. A un certo punto parla Ilaria Fiorillo, che gestisce la pagina Instagram milano_in_bicicletta:
Le persone che vanno in bici non si sentono sicure, perché manca la cultura di base della bicicletta. Chi guida un’automobile non è disposto a condividere le strade su cui circoliamo o i marciapiedi, che vengono usati come parcheggi.
Eccolo il punto focale: il rispetto e la condivisione degli spazi.
Della città di Milano leggo soltanto, perché io sto a Brescia, di sicuro però il suo tessuto urbano è complesso, ci devono coesistere tanti e diversi flussi: auto, veicoli commerciali, moto, motorini, autobus, tram, biciclette, pedoni.
La varietà è lo stato naturale di ogni cosa, ed è così sia per i nostri habitat urbani sia per quell’habitat in cui ci muoviamo ogni giorno, ovunque viviamo: la lingua.
La lingua è il nostro habitat naturale, perciò riuscire ad avere le parole giuste per nominare cose e persone ci consente di fare un sacco di cose:
esprimere in modo chiaro quello che sentiamo
trovare le parole per descrivere il mondo che ci circonda
comunicare con le altre persone
Gianni Rodari diceva così:
Tutti gli usi della parola a tutti: mi sembra un buon motto, dal bel suono democratico. Non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo.
Ci dice (anche) che le parole sono come un prisma, hanno tanti lati e riflettono diverse luci: tutti quelli che sono propri di ogni persona, che è diversa da qualunque altra ed è fatta da un insieme di caratteristiche diverse.
Disporre della ricchezza di un ampio materiale linguistico ci consente di essere precisə, soprattutto di fare esistere nello stesso sistema anche quelle parole che finora erano rimaste nascoste. O meglio: che erano state messe nell’ombra.
Fare un passo indietro
Gli spazi sono diversi dai luoghi. Il luogo è un ambiente circoscritto, chiuso, separato; lo spazio accoglie dentro di sé diversi luoghi, è per vocazione qualcosa di aperto in cui vari luoghi possono coesistere.
Soprattutto lo spazio è qualcosa che possiamo modulare, spostare, cambiare. Per mantenere il paragone ciclistico dell’inizio, raccolgo un pezzo di quello che un paio di anni fa disse Giovanni Storti in una delle interviste organizzate da Fa’ la cosa giusta e intitolata Chiedimi se sono felice … in sella!, minuto 16’04’’ (però ascoltatelo per un paio di minuti, anche perché Giovanni tira fuori anche una chicca che fa sbellicare dalle risate):
Andare in bicicletta in ambito urbano è pericoloso, purtroppo.
Da una parte negli ultimi vent’anni a Milano la situazione è migliorata, ci sono più piste ciclabili; dall’altra parte gli automobilisti si sono incattiviti un po’ con i ciclisti, forse perché hanno paura che i ciclisti prendano troppo spazio.
Eccolo, lo spazio che ci interessa: quello da lasciare. Quello detenuto da chi ha (e finora ha avuto) il potere di prenderselo, quello spazio. Ed è questione di lasciarlo anche e soprattutto in ambito linguistico.
Chi ha occupato spazi che sono diventati la norma, deve lasciarli a chi non ha mai avuto la possibilità di mostrarsi, a chi è (stato messə) in minoranza, che questa sia espressa dal colore della pelle, dall’identità di genere, da corpi non conformi, dall’età, dalle abilità fisiche, dalla nazionalità.
E per farsi vedere anche agli occhi delle altre persone, per esistere nel discorso pubblico, gli servono le parole.
A spiegare però meglio di chiunque altrə questa cosa è la giornalista Kübra Gümüsay nel suo libro Lingua e essere, perciò vi riporto un ampio stralcio:
Proviamo a pensare alla lingua come a un luogo. Come a un museo straordinariamente grande, nel quale ci viene spiegato il mondo che c’è fuori. Potreste passare settimane, mesi, anni, una vita intera in quel museo, quanto più tempo ci trascorrete, tante più cose finite per comprendere. Potreste immergervi in mondi di cui non avete mai avuto un’esperienza diretta, che lì sono disposti con un ordine e divisi in categorie, resi comprensibili attraverso nomi e definizioni. Ci trovate oggetti, esseri viventi e piante da tutti i continenti, ma anche idee e teorie, pensieri e sentimenti, fantasie e sogni. Di un passato molto lontano, ma anche estremamente attuali.
Ci sono due categorie di esseri umani in questo museo: i nominati e gli innominati.
Gli innominati, ovvero coloro che non hanno ricevuto un nome, sono esseri umani la cui esistenza non viene analizzata. Sono lo standard. La norma. Il metro di paragone.
Spensierati e liberi, gli innominati camminano nel museo della lingua. Poiché è fatto per persone come loro. Mostra il mondo dalla loro prospettiva. E non è un caso, dal momento che sono gli innominati a curare le esposizioni del museo. Sono loro a decidere cosa mostrare e cosa no, danno loro i nomi alle cose, classificano loro le definizioni. Sono innominati, eppure loro stessi esercitano il potere di denominare. Sono anche i nominanti, ovvero coloro che danno i nomi.
Esatto, il museo della lingua ci apre il mondo. Ma in nessun modo lo comprende nella sua totalità, in tutta la sua ricchezza di sfaccettature. Comprende purtroppo solo quello che comprendono i nominanti – fino a dove arrivano i loro sensi e le loro esperienze. Non oltre.
Gli altri innominati non si accorgono di questa restrizione, non si accorgono neanche che il loro sguardo sul mondo è governato da altri esseri umani. Diventa chiaro quanto liberi e spensierati possano muoversi nel museo della lingua solo quando osserviamo in questo museo la seconda categoria di esseri umani: i nominati, ovvero coloro che hanno ricevuto un nome. Prima di tutto sono semplicemente esseri umani che in qualche modo deviano dalla norma degli innominati. Anomalie nella concezione del mondo degli innominati. Non previsti. Strani. Diversi. Talvolta anche banalmente inconsueti. Sconosciuti. Provocano incertezze. Non sono normali.
Gli innominati vogliono capire i nominati – non come individui, ma come collettivo. Li analizzano. Li controllano. Li classificano. Li catalogano. Alla fine danno loro un nome collettivo e una definizione, che li riduce a segni caratteristici e proprietà che gli innominati credono siano tipici in loro. E questo è il momento in cui da esseri umani si diventa dei nominati. In cui gli esseri umani vengono disumanizzati.
Questi esseri umani, che però non lo sono più – i nominati –, vivono accuratamente catalogati in teche di vetro, etichettati con il loro nome collettivo. Noi li osserviamo attraverso gli occhi degli innominati: esseri senza faccia, elementi di un collettivo. Ogni loro espressione, ogni loro comportamento viene ricondotto al collettivo, l’individualità non è più consentita. Agli innominati che li osservano tutto questo sembra normale, per quanto loro stessi considerino l’individualità il fondamento del loro Essere.
Lo spazio non va concesso perché vorrebbe dire continuare a mantenere un controllo remoto della macchina, lo spazio va lasciato, vanno abbandonati i comandi.
Va fatto un passo indietro per liberare spazio.
Lo spazio si libera scegliendo di usare le parole giuste, cioè quelle che definiscono in modo puntuale una cosa, una situazione, una persona. E l’esempio più lampante è quello dei femminili professionali.
Perciò, Maria Sole Ferrieri Caputi è semplicemente l’arbitra che domenica ha diretto Sassuolo - Salernitana, la prima donna ad averlo fatto nel campionato di serie A. Peccato che molti quotidiani nazionali non hanno saputo dare la notizia senza indulgere in un uso della lingua resistente ai cambiamenti, come ben raccontato da questo pezzo di Internazionale.
La lingua conta
Spesso all’interno di gruppi o in caso di iniziative/eventi capita di sentire qualcuno che dice “dobbiamo aumentare le quote rosa”, parlandone come qualcosa che risolva la parità, qualcosa che in ogni caso viene concesso.
Piuttosto che solo di quote rosa, cioè di una parte numerica, si dovrebbe parlare di persone che rappresentino l’estesa varietà umana — e quindi i molteplici punti di vista sulle cose. Non solo il genere (e non solo nella sua forma binaria), ma anche l’età, la provenienza, le abilità fisiche.
Come ho sentito dire a Vera Gheno nell’intervento al festival Librixia:
Il linguaggio è più complesso della matematica, perché non è prevedibile.
Fare un passo indietro è sempre la disposizione giusta quando si sente di occupare uno spazio in maniera indebita o per via di un privilegio, e a volte la parola che riesce ad aprire le porte al dialogo è piana e fatta di due sole sillabe: scusa.
Se capita di dire qualcosa di sbagliato, qualcosa che offende, basterà usare quel semplice bisillabo. E non l’ormai abusata formula “mi dispiace se con le mie parole ho offeso qualcuno”, perché quest’espressione denota lo scompenso di posizioni paternalistico di chi scarica sulle altre persone la “colpa di essere diverse dalla norma”.
Il modo in cui nominiamo e raccontiamo fa la differenza. E se ci vengono dei dubbi sul come nominare, il miglior modo di agire è lasciare spazio alle altre persone di definirsi, tutt’al più chiedere come vogliono essere chiamate.
Fare un passo indietro, chiedere scusa, lasciare la parola.
Tre cose che ci aiutano a dare pari dignità a tutti i pensieri, perché riescono tutt’e tre a farne una che conta più di tutte: ascoltare.
Come diceva la scrittrice femminista bell hooks:
“È ai margini che accadono le cose”.
E quei margini è bene esplorarli silenziosamente, per ascoltare la parola di chi finora ha vissuto fuori dal centro del discorso.
📚 Emergere dai bordi
Visto che l’ho citata proprio in chiusura, di bell hooks suggerisco un libretto che si legge agilmente e crea tanto ma tanto spazio di pensiero: s’intitola Il femminismo è per tutti e vi riporto proprio due righe in cui dentro allo spazio da conquistarsi arrivano i bambini:
La letteratura per l’infanzia è uno dei siti cruciali per l’educazione femminista alla coscienza critica, proprio perché idee e identità sono ancora in formazione.
Secondo consiglio è per una pubblicazione a cura dell’associazione culturale Hamelin, che si occupa di educazione alla lettura (e che è dietro la cura del festival internazionale di fumetto BilBOlbul): si tratta di Fare spazio. Riflessioni e conversazioni sul graphic novel in Italia, un bel titolo per raccontare le modalità con cui un genere da sempre ai margini è riuscito ad acquistare visibilità, credibilità, riconoscimento culturale.
📺 Vite nascenti
Ci sono tante voci nel margine, stanno lì pronte a prendere più aria nei polmoni per riuscire a parlare e raccontarsi. Ce ne sono molte anche in una serie tv che da poco ho finito di vedere: Prisma, che è capace di raccontare fragilità e sfumature di un mondo di adolescenti che è specchio della varietà di qualsiasi società. Sta su Prime Video.
E poi fa da gancio a un’altra serie tv scritta dalla stessa coppia artistica (Ludovico Bessegato & Alice Urciuolo): SKAM Italia, che se non l’avete vista, vedetela e innamoratevene. Sta su Netflix.
🗞️ La pluralità dei valori
Un pezzo di Annalisa Ambrosio su Doppiozero ragiona intorno al concetto di pari opportunità, portando alla luce la complessità delle persone, contro una forma mentis rigida e schematica che le obbligherebbe a stare dentro una gabbia stretta.
🔥 Bonus track ciclistico
Dato che sono partito dal paragone con le due ruote, lancio sulla strada tre profili:
ciclistepercaso, cioè un progetto con cui Silvia Gottardi e Linda Ronzoni parlano di viaggi ma soprattutto di donne ed empowerment, prendendo come spunto la bicicletta.
copenhagenizers per vedere come funziona la ciclabilità nel paese in cui ci sono più biciclette che abitanti: la Danimarca.
cyclelogistics che cerca di diffondere la cultura delle cargo bike in tutta la vasta Europa.
Mi sa che è tutto, noi ci leggiamo alla prossima Linguetta!
Mi raccomando: fermiamoci, pensiamo, lasciamo spazio e ascoltiamo chi ancora non ha avuto la parola. Sarà un atto fatto col cuore, che poi è lo stesso 💖 che potete metterci per dirmi se v’è piaciuta la puntata. Basta pigiare il pulsante qui sotto.
Lo spazio accanto al cuoricino è sempre per voi: spazio libero di commento. Se invece ne volete uno più intimo, leggo e rispondo via mail.
Mentre per allargare gli spazi social di Linguetta, il nome da taggare su Instagram insieme alla puntata è andrjet.
E da oggi Substack arriva anche come app per dispositivi Android (prima c’era solo per iPhone). Perciò, se vi va di seguire Linguetta dentro un’ecosistema pensato per gli smartphone, ecco il pulsantone per scaricare l’app di Substack.