Essere funzioni
Linguetta #104 / La matematica è un linguaggio che spesso scansiamo, ma riesce a rendere evidenti le relazioni. Ed è un'altra preziosa forma di espansione linguistica.
Ehilà, eccomi con una nuova Linguetta!
Qualche settimana fa mi sono alzato con in testa tre parole: studio di funzione. Mi è parso di essere tornato agli anni del liceo scientifico, che attraversai faticando tra calcolo dei limiti, integrali, derivate, potenziale e altre cose matematico-fisiche.
Diciamo che alle superiori mi sentivo come la protagonista del romanzo per ragazzə Julia e lo squalo di Kiran Millwood Hargrave (illustrazioni di Tom de Freston, traduzione di Marta Barone), che all’inizio dice:
La mia cosa preferita sono le parole. Si possono trasformare i numeri in parole, ma non si possono trasformare le parole in numeri, e quindi le parole devono per forza essere più potenti, no? […]
Papà non è d’accordo. Lavora solo con i numeri.
Ecco, anche mio papà ha sempre lavorato con i numeri, facendo calcoli ingegneristici. Allora è a lui che mi sono rivolto per avere una definizione chiara e sintetica del mio risveglio matematico. Ecco la risposta:
Studiare una funzione significa capire come un elemento varia rispetto a un altro.
“Allora siamo tutte funzioni”, mi è venuto da dire.
E mio papà mi ha detto che la mia domanda gli aveva fatto venire in mente — a volte le coincidenze, o sono segni? — una cosa vista il giorno prima nello stato WhatsApp di un collega, una formula matematica che qualche ora più tardi ha recuperato online e mi ha girato. Questa qua:
Mi piacciono le formule matematiche, adesso. Questa in particolare dice che la vita è l’integrale che va dalla nascita alla morte del rapporto tra felicità e tempo in tutte le piccole frazioni di quel tempo.
Le formule sono storie.
L’integrale ho sempre faticato ad afferrarlo, forse perché a scuola le insegnanti non sono mai riuscite a farmelo visualizzare. Non è altro che un’area, tiene dentro le cose, l’integrale. E le definisce in uno spaziotempo.
È un principio ordinatore l’integrale, una specie di lente d’ingrandimento che permette di leggere un pezzetto di realtà.
Che è quello che possiamo fare noi osservando la lingua che cambia, un pezzetto alla volta, sotto i nostri occhi, attorno alle nostre orecchie. Cambia perché la società in cui viviamo cambia, un pezzetto alla volta.
La lingua è la derivata della realtà.
Il nostro studio di funzione umano sta coi piedi piantati nella realtà per capirla in ogni sua sfumatura, perché alla fine sono le tante piccole diversità che determinano la realtà.
Le parole sono uno dei linguaggi che possediamo, i numeri pure. Usandoli entrambi possiamo conoscere ancora meglio le cose, capire che i numeri sono espressioni di azioni e intenzioni, che non sono granitici e sono interpretabili, come racconta sempre con grande precisione
nella sua newsletter .Vi linko una delle ultime puntate in cui spiega passo passo che domande farsi per leggere i dati di una notizia:
Parole che funzionano
Sempre nel romanzo che ho citato all’inizio, la protagonista Julia dice un’altra cosa:
Anche mamma lavora con i numeri, ma preferisce le parole. È una scienziata, e questo significa che devi amarli entrambi.
I numeri ti aiutano a tenere traccia delle cose, ma solo le parole possono aiutarti a spiegarle.
Ci sono tante cose dentro questi due pensieri, la più bella è che la cultura non funziona per compartimenti stagni.
Le discipline sono permeabili l’una all’altra.
La scrittrice Chiara Valerio è una che ha studiato e insegnato matematica per anni, oltre ad avere un dottorato di ricerca in calcolo delle probabilità. È una di quelle persone che mi piace moltissimo leggere e ascoltare, perché nei suoi pensieri c’è sempre una convergenza di cose che provengono da ambiti diversi.
Nel suo saggio La matematica è politica parla anche della matematica a scuola, dove spesso viene insegnata “fuori dal tempo e dallo spazio, dunque fuori dalla storia”.
Ma la matematica è come le parole: ha a che fare con la materia.
Dice Valerio:
Nessuna civiltà è pervasa di matematica come la nostra. Algoritmi, previsioni, automazioni, calcoli, cronometri, gps, conteggi energetici per perdere peso o acquistarne, lotterie, contapassi.
E capire i numeri significa capire le persone, e per riuscire a capirli serve affidarsi a chi ce li può spiegare, anche e soprattutto con le parole. Si tratta anche in questo caso di parole espanse, cioè di un modo di dare più corpo alle parole. Ancora Chiara Valerio:
Numeri e cose. Numeri e persone. Ma più di tutto relazioni tra una cosa e l’altra, tra una persona e l’altra, e tra cose e persone.
È tutto una funzione.
Tutto riguarda sempre le persone, cioè come ci rivolgiamo a ciascuna di loro per farle funzionare.
Ricordandoci di non separare numeri e parole, tecnica e sapere, discipline scientifiche e discipline umanistiche. Tutte quante le discipline hanno a che fare con l’umano, perché riguardano cose, pensieri, domande, dubbi umani.
Come ho sentito dire all’imprenditore digitale Giacomo Mason, “la distinzione tra materie dello spirito e materie tecnologiche è il motivo per cui in Italia abbiamo tavoli tecnici nelle pa (pubbliche amministrazioni), mentre nel Regno Unito no”: cioè permane quella divisione di saperi che condanna numeri e parole a stare seduti in due stanze diverse.
Sapere è contaminare
Niente è fisso e separato, e anche se la matematica (come la lingua) sta dentro un sistema di regole, queste sono continuamente negoziabili.
Lo spazio di un futuro culturale è fatto di parole e numeri e persone sempre incerte. Che poi è il processo del conoscere, che conduce al dubbio ed è principio democratico.
Lascio la chiusura, con un pensiero matematico, ancora a Chiara Valerio, quando nel suo libro parla di superadditività, cioè quel principio per cui (x+y)2 essendo pari a x2+y2+2xy è maggiore di x2+y2:
Ecco, la vita singola e la vita collettiva godono di una superadditività che fa sí che nessuno di noi sia la mera somma dei propri dati biologici, giuridici, virtuali, ma sia qualcosa di più.
La stessa democrazia è superadditiva, lo Stato è qualcosa di più rispetto all’azione congiunta di potere legislativo, esecutivo e giudiziario.
Questo qualcosa di più […] penso sia il linguaggio, che ci rende non riconducibili alle nostre caratteristiche e informazioni biologiche, genetiche e tecnologiche perché permette di raccontare.
E raccontando di creare versioni. Siamo anche quello che tutti gli altri vedono di noi.
I numeri servono a contare, soprattutto a far contare le persone.
I numeri come le parole aiutano a capire chi siamo, capire chi sono le altre persone, capire tutto quello che sta nel mezzo.
E capire è avventuroso.
P.S.
Saltello al sabato con una puntata numerica, ma serve sempre guardare ai lati e al di là dei passi che facciamo di solito.
Ah, se volete scalare la classifica dei premi, il bottone che vi porta al magico link per diffondere Linguetta è questo qui sotto.
🖊️ Inversi
Due versi brevissimi che sono come un’equazione matematica. Li ha scritti Patrizia Cavalli, stanno nella raccolta Poesie (1974-1992).
Io qui. Tu là.
Tu lí. Io qua.
📚 Storie numeriche
L’ho citata parecchio nella puntata, e allora vi consiglio un altro libro di Chiara Valerio: Storia umana della matematica, un saggio in cui ogni capitolo è dedicato al racconto di una persona che ha usato la matematica per capire il mondo. E com’è proprio di Valerio, dentro ci entrano un sacco di cose disparate e aneddoti personali.
Il secondo consiglio è invece la raccolta Racconti matematici curata da Claudio Bartocci, docente di fisica matematica all’università di Genova. Ventisei racconti che indagano gli spazi matematici. Ne cito alcuni dei miei preferiti: Il libro di sabbia di Jorge Luis Borges, I sette messaggeri di Dino Buzzati, Quanto scommettiamo di Italo Calvino, Continuità nei parchi di Julio Cortázar, L’uomo matematico di Robert Musil.
🎧 In punta di piedi
Non mi ricordo come l’ho scoperto: si chiama Butterflies & Ballerinas ed è il racconto in quattro puntate del viaggio che lo scrittore Michele Dalai ha fatto in Danimarca, insieme a due amici, per capire chi era Hans Christian Andersen e come ha fatto a diventare Hans Christian Andersen.
🗞️ L’istruzione è politica
Visto che ho parlato di naturale contaminazione dei saperi, vi segnalo l’articolo Dall’istruzione alla formazione di Giacomo Tinelli per Il Tascabile: una riflessione sulla recente riforma scolastica (decreto legislativo n.61, del 13 aprile 2017 e seguenti atti normativi) che riguarda le scuole professionali, viste come destinatari di “pacchetti culturali di sapere commerciabile”.
Mi sa che è tutto, noi ci leggiamo alla prossima Linguetta!
Usiamo anche i numeri della matematica per vedere meglio cose e persone, basta partire dal 💖, lo stesso cuore che sta qui sotto e che potete pigiare per dirmi se v’è piaciuta la puntata.
Per lasciare un commento c’è lo spazio lì accanto, ma vi aspetto pure via mail, oppure dentro le Notes con un restack della puntata (cioè pigiando la rotellina con le due frecce accanto al simbolo dei commenti).
Se volete taggarmi su Instagram, cercatemi come andrjet.





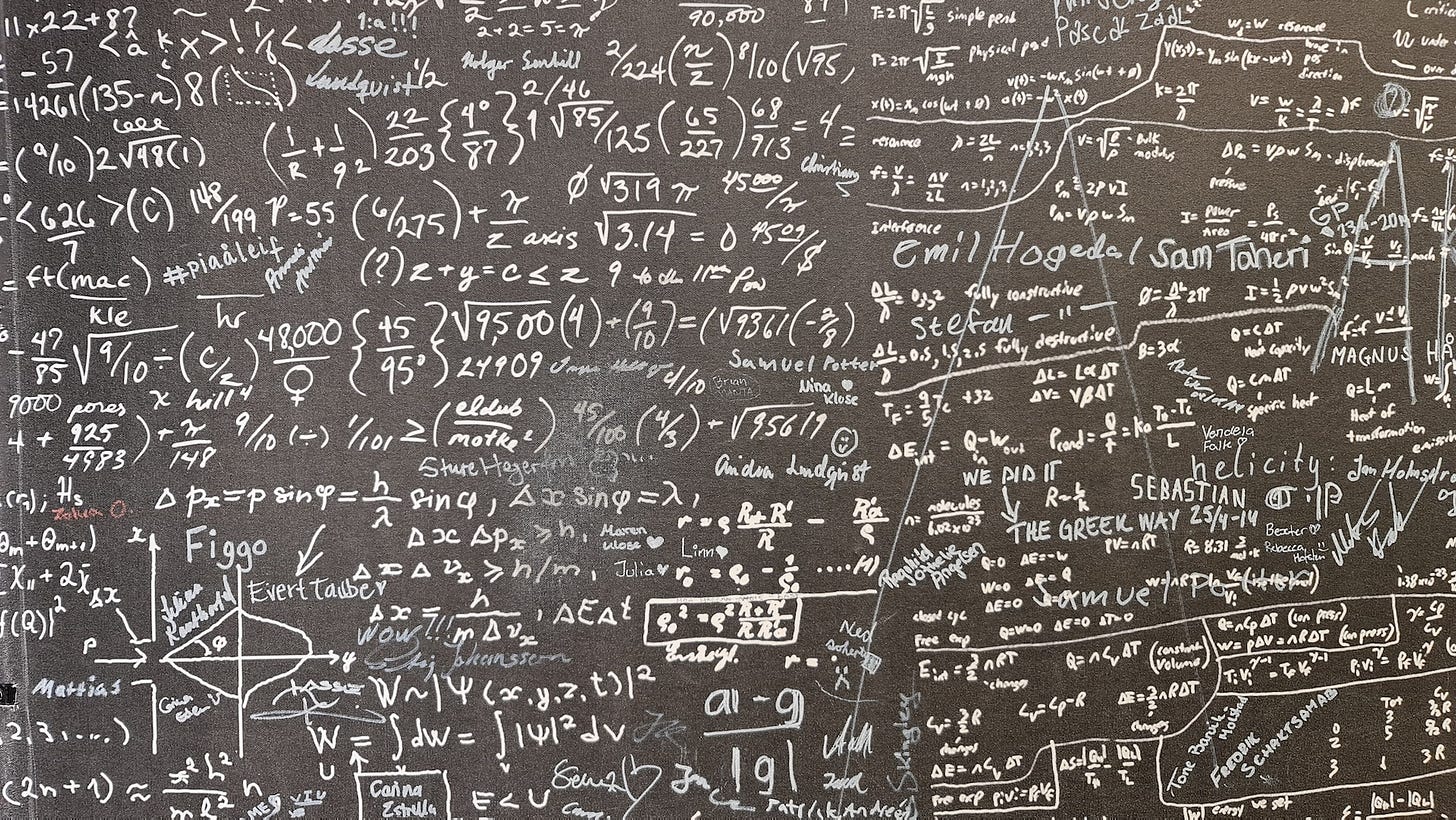












Bellissima anche stavolta!