Curare lo (stra)ordinario
Linguetta #86 / Scegliere le parole giuste per descrivere il cambiamento climatico è troppo importante, e serve a guardare lontano per produrre azioni ogni giorno.

Ehilà, eccomi con una nuova Linguetta!
Pochi giorni fa uno dei miei nipoti (seconda elementare) era impegnato nel leggere ad alta voce le operazioni degli esperimenti scientifici fatti a scuola; ogni tanto c’erano delle cose fra parentesi, e lui quelle parentesi le pronunciava come tutto il resto.
Dopo averlo ascoltato con attenzione, quando aveva letto tutto con puntiglio, gli ho chiesto questa cosa:
Io: Ma dentro alle parentesi, che cosa dici che c’è?
Lui: Ci sono scritte le cose più importanti.
Ecco, è bastato un secondo per ribaltare un concetto.
Siamo abituatə a pensare alle cose che stanno fra parentesi come qualcosa che possiamo saltare, di superfluo, che non aggiunge niente di più a quello che sta fuori.
In realtà le parentesi interrompono il discorso per fare precisazioni, osservazioni, chiarimenti, digressioni. Per dire cose che ne sottolineano altre, che non vedremmo se non fossero chiuse tra quelle due curve a ombrello.
Le parentesi sono come cannocchiali: ci fanno guardare lontano senza allontanarci dal posto in cui siamo.
Come la lingua, con cui possiamo guardare lungo curando l’ordinario.
La lingua ha questo superpotere, che è come la supervista di bambine e bambini: ci fa vedere in lungo senza trascurare quello che nell’immediato possiamo fare con le parole.
Ed è una cosa che possiamo praticare ogni giorno parlando del cambiamento climatico, in modo consapevole e attento.
Le parole del clima
Nel 2018 fu la tempesta Vaia in Trentino, poi Liguria, Toscana, Venezia, Modena, Ferrara, la Marmolada, Ischia. Ora gran parte dell’Emilia Romagna. E nel mezzo tanti altri luoghi che sono stati colpiti da eventi climatici estremi, ma che poi fatichiamo a ricordare.
Riconoscere che questi sono fenomeni devastanti con effetti devastanti è necessario, deve diventare il nostro modo di nominarli, raccontarli, di parlarne: su giornali, in tv, online ma soprattutto a voce, fra di noi.
Certo che un solo evento estremo non è segno diretto della crisi climatica, ma tanti ripetuti eventi estremi lo sono. E sono anche un solo pezzo del quadro, nel quale rientrano le scelte urbanistiche e il consumo di suolo, come racconta benissimo Ferdinando Cotugno su Domani (il pezzo s’intitola Cementificazione o gas serra? I due fronti della crisi climatica).
Le parole servono a definire la realtà.
Il rapporto è vicendevole, muta continuamente e si adatta al cambiamento dei contesti e delle condizioni. Cambiano le cose e cambiano pure le parole per dirle, quelle cose.
Scriveva Tommaso Perrone, direttore di LifeGate, in un post su Instagram dello scorso agosto:
La parola maltempo è insufficiente e non è in grado di esprimere la realtà dei fatti. I mezzi di informazione devono adeguare il loro glossario ai tempi che corrono.
Perché le parole sono importanti e spesso contribuiscono a generare azione.
Ecco un’altra cosa bella delle parole, che non sono mai “solo parole”. Le parole fanno succedere, fanno accadere le cose, possono produrre azioni concrete.
Ed è in questa simbiosi che possiamo stare — mi viene da dire dobbiamo stare —, perché le cose si cambiano insieme. Se una parola la tengo soltanto per me, non fa niente, è sterile. Serve parlarne, e parlarne con la consapevolezza di usare parole appropriate per nominare i fenomeni e trovare soluzioni.
Usarne meno, usarle meglio. Siamo sempre lì: al pensare (tanto) prime di dire le cose, a strutturare un pensiero complesso come il cambiamento climatico, che non va affrontato come scontro tra tifoserie (specie negli studi televisivi).
Ogni fenomeno è complesso (cioè stratificato, composto di tante cose diverse) però noi possiamo prenderci il tempo di riflettere, di sentire chi ha competenze e conoscenze approfondite, sviluppate studiando i vari pezzi di un dato problema. E poi possiamo chiamare le cose con il loro nome.
Prevenire, dire, fare
C’è una parola che salta sempre fuori di fronte a eventi climatici estremi (che siano alluvioni, frane, valanghe, siccità, gelate, tempeste) e alle conseguenze che portano: la parola è imprevedibilità.
Un reel Instagram del dottore forestale Riccardo Rizzetto fa una bella sintesi della cosa, ed è proprio il riuscire a dare i nomi giusti alle cose che permette di arginare questa imprevedibilità. E riguarda due parole astratte che però hanno effetti evidenti e duraturi: prevenzione e precauzione.
L’emergenza climatica rende sempre più probabili e frequenti gli eventi estremi, facendo sì che impatto e pericolosità siano maggiori. Ed è una cosa che la comunità scientifica va ripetendo con prove indiscutibili da anni (anzi, da decenni).
Ormai famosa (ma sempre utile da rivedere) è la spirale climatica a cura della NASA, una visualizzazione animata che mostra le anomalie mensili della temperatura globale (variazioni rispetto alla media) tra il 1880 e il 2021.
I bianchi e i blu indicano temperature più basse, mentre gli arancioni e i rossi indicano temperature più calde. Come si può notare, le temperature globali si sono riscaldate soprattutto a causa delle attività umane, con il passare del tempo.
Riuscire a comunicare in modo ponderato e supportato da evidenze scientifiche è ineludibile, ci spetta. Ed è sempre la lingua che può aiutarci, ad esempio continuando a ripetere che meteo e clima sono differenti: il meteo è puntuale e locale, il clima invece prende in esame l’andamento delle condizioni atmosferiche in un lungo periodo (di almeno 30 anni).
Le parole ci aiutano a definire (e capire) i fenomeni.
Gli effetti delle parole che stanno tra parentesi servono a vedere lontano, spiegano le cose più importanti (come mi ha fatto notare mio nipote) e ce le mettono lì davanti al naso.
Si tratta delle cose straordinarie che possiamo ottenere curandoci bene dell’ordinario.
Ora, nell’emergenza non occorre usare parole per cercare i colpevoli né usarne per demolire chi nega il cambiamento climatico.

Serve fare le cose pensando in lungo, e per farle si comincia sempre dalle parole.
P.S.
In questa puntata di Linguetta ho usato (intenzionalmente) un bel po’ di parentesi, ma mi sembrava giusto allinearmi anche formalmente al discorso sul cambiamento climatico che troppo spesso mettiamo tra parentesi senza leggere che cosa ci sta dentro.
E nel fare tutto questo ho di nuovo saltato in avanti di un giorno con la puntata, stavolta a mo’ di canguro (che da quel che ho capito emette, a volte, uno specie di bramito, ma chiederei aiuto a
di ).🖊️ Inversi
Oggi pochi versi di Alfonso Gatto, che è stato tante cose (poeta, pittore, critico d’arte, critico letterario, e come scrittore pure inviato al Giro d’Italia). C’era il gusto del surrealismo nelle sue poesie.
La luna
Si spensero i fanali
restò la luna sui davanzali
grigia e rosa come un duomo
ove cantano le vocali.
📚 Scritti e disegnati
Il primo consiglio è per Lettera tra due mari di Siri Ranva Hjelm Jacobsen (traduzione di Maria Valeria D’Avino, illustrazioni di Dorte Naomi): un libro agile, tanto che non ha nemmeno i numeri di pagina; un dialogo tra due corrispondenti (Atlantica e Mediterranea) che si raccontano e raccontano il nostro pianeta liquido, dicendoci della relazione disconnessa e traballante fra umani e ambiente.
Il secondo invece è un albo illustrato che credo riesca come pochi altri a fare sintesi di tutto quello che riguarda il mutare delle condizioni della Terra per via dell’impatto umano. S’intitola Cambiamento climatico, l’hanno scritto l’antropologa Yayo Herrero López e la biologa María Gonzalez Reyes, con le illustrazioni di Berta Páramo Pino (traduzione di Violetta Colonnelli).
🎧 Chiamami col mio nome
Consiglio di ascoltare la puntata del 18 maggio di News dal pianeta Terra, in cui Giovanni Mori fa una riflessione linguistica molto puntuale e chiara su come nominiamo le azioni del cambiamento climatico.
🗞️ Riflessioni liquide
Il quinto di una serie di cinque pezzi comparsi su Doppiozero e riguardanti i mutamenti climatici che abbiamo indotto noi umani. S’intitola Mari e monti (4). Oceano, sostantivo singolare e, citando anche altri libri, parla di ecologia del linguaggio marino. Un passaggio:
A proposito dell’oceano, il filosofo Roberto Casati (pp. 152-3) propone di adottare un nuovo lessico: non più riserve ittiche ma popolo extraterrestre; non più giacimenti petroliferi ma zone sottomarine di protezione atmosferica; non risorsa ma condizione di sopravvivenza; non gas naturale ma gas fossile; non pesca ma estrazione meccanica. […]
Si potrebbe anche presentare l’aumento della temperatura del mare come una forma di febbre” (in Casati, p. 156).
Mi sa che è tutto, noi ci leggiamo alla prossima Linguetta!
Le parole cambiano la narrazione di quello che accade, proviamo a usarle consapevolmente. Basta volere bene alla casa che abitiamo, perciò serve prima di tutto il 💖, lo stesso cuore che sta qui sotto e che potete pigiare per dirmi se v’è piaciuta la puntata.
Per lasciare un commento c’è lo spazio lì accanto, ma vi aspetto pure via mail, oppure dentro le Notes con un restack della puntata (cioè pigiando la rotellina con le due frecce accanto al simbolo dei commenti).
Se volete taggarmi su Instagram, cercatemi come andrjet.













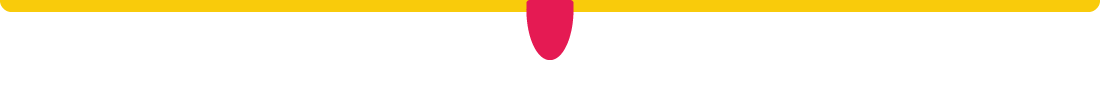
Ok, Andrea, l’hai voluto tu: nella prossima newsletter parlerò (anche) di canguri!