Figurarsi
Linguetta #107 / In ogni cosa che facciamo sono immagini e immaginazione che ci guidano nel costruire il mondo, anche quando non sono gli occhi a poterlo fare.

Ehilà, eccomi con una nuova Linguetta!
All’inizio del suo libro Che cosa vediamo quando leggiamo l’art director Peter Mendelsund dice (o meglio raffigura) queste parole:
C’è una storia che si chiama “Lettura”.
La conosciamo tutti.
È una storia di immagini e di immaginazione.
Noi umani siamo esseri visuali.
Concepiamo e visualizziamo il mondo per figure, e anche se nel processo di lettura quello che ci figuriamo non sono immagini stabili e definite (ma più simili all’opacità dei ricordi), funzioniamo sempre per immagini.
Il nostro cervello decodifica ogni cosa secondo il codice visuale, e anche se non vediamo — perché siamo persone cieche dalla nascita, diventate cieche o ipovedenti —, la radice etimologica di immagine è la stessa di immaginazione.
E il dizionario etimologico Zanichelli dice che l’immaginazione è “la facoltà di pensare senza regole fisse e di associare liberamente i dati dell’esperienza”.
Siamo creature immaginative.
Ognunə di noi usa i sensi di cui dispone per fare esperienza di quello che lə circonda e poi rielaborare le informazioni ricevute.
Funziona così anche con le parole — che noi le leggiamo o le ascoltiamo —: comunque le codifichiamo per figurarci una situazione, una sensazione, un’atmosfera, un’intenzione.
Sinestesie viventi
Ci figuriamo continuamente le cose, e anche se non possiamo vederle, sono udito, tatto, olfatto, gusto che possono descriverle al nostro cervello. Sempre l’etimologia dice che:
l’immagine è la forma esteriore di un corpo percepita coi sensi
Quell’ammasso di neuroni e glia che sta dentro la scatola cranica è una specie di congegno sinestetico.
La sinestesia fa collidere due sfere sensoriali, e allora possiamo vedere il suono del mare o sentire “l’aspro odor de i vini”.
Immagino sia questo il meccanismo che s’innesca per le persone cieche, almeno dalle letture che ho fatto — ma in futuro mi piacerebbe dedicare delle puntate di Linguetta alle unicità che contraddistinguono le persone, lasciando magari il racconto alla loro voce.
Le sfumature di ogni persona sono diverse, ed è la stessa cosa che Peter Mendelsund dice dell’immaginazione, che non è una cosa granitica ma più uno spettro:
Penso che l’immaginazione sia come la vista; la maggior parte delle persone possiede questa facoltà. Anche se, ovviamente, non tutti vedono con la stessa acutezza […]
Credo che quando tessiamo le lodi dell’immaginazione di un autore, quel che stiamo elogiando sia la sua capacità di trascrivere le visioni che ha.
La capacità di tradurre tutto ciò che percepiamo in entrata verso il cervello e poi di ritradurlo a noi stessə in uscita, per raccontarcelo, cambia a seconda di chi siamo.
Ecco perché credo siano atti linguistici i dispositivi come linee zigrinate nelle stazioni, percorsi urbani marcati, segnali acustici di attraversamento, audioguide, audiolibri, podcast, descrizioni in braille: tutti quanti rendono più leggibile il mondo.
E lo fanno per le persone che vedono, per quelle cieche, per tuttə.
Vedere di più
Se ci pensiamo siamo permeatə dal senso della vista, che torna in tante espressioni di uso comune, anche se il significato slitta pure verso altri sensi. Qualche esempio:
l’hai visto l’ultimo film di Nolan?
visto che roba!
ci siamo vistə proprio ieri in libreria
ci siamo persi di vista
ahia, guai in vista!
a prima vista non direi
la neve aumenta a vista d’occhio
hai la vista lunga, eh!
ho appena rinnovato il visto
visto si stampi
in tv fanno Chi l’ha visto?
lə marca a vista
mettilo in bella vista
a prima vista non sembra propio
no, lə conosco solo di vista
ci vediamo!
Riuscire a vedere il mondo anche quando gli occhi non sono la periferica principale del nostro cervello è un diritto, che si esercita sempre in quella terra in cui normalità si declina solo al plurale, cioè come tante differenze.
Si può fare e si sta già facendo, come in questi tre bei casi:
L’audiodescrizione poetica presente nello spettacolo Earthbound di Marta Cuscunà.
L’invito a toccare le opere d’arte nel museo tattile statale omero di Ancona.
I quattro videogiochi acustici raccontati nel pezzo Giocare con le orecchie che
ha scritto per l’ultima puntata di .
Spettacoli, musei, videogiochi sono tre importanti luoghi di accoglienza, soprattutto sono tre zone culturali in grado di fare vedere che la società è fatta di tante piccole cose, che il modo in cui vediamo noi è solo uno degli 8 miliardi di visioni possibili.
Si tratta di progettare mettendosi nei panni delle persone, anzi chiedendo a loro di partecipare alla progettazione per capire come renderla utile per una particolare caratteristica.
Nel caso di questa Linguetta ad esempio aggiungo a posteriori il voiceover (cioè la trascrizione audio della puntata); e immediatamente gli alt text (cioè la descrizione scritta di quello che compare in ogni immagine, valido sia per chi non vede sia nel caso la rete vada a singhiozzo e non riesca a caricare immagini e gif), come ho imparato a fare sistematicamente, leggendo e seguendo i consigli sull’accessibilità di
.Possiamo contare ancora una volta sulla lingua, che insegna proprio questo: chiedere alle persone come si fanno le cose, e ascoltarle.
Riesce a farlo perché sa immaginare, e come diceva Bruno Munari:
L’immaginazione è il mezzo per visualizzare, per rendere visibile ciò che la fantasia, l’invenzione e la creatività pensano. L’immaginazione in certi individui è molto tenue, in altri è fervida, pronta, in altri va oltre il pensato.
E contiene dispositivi potenti come la metafora (anzi funziona proprio grazie alla metafora), che è un po’ come i quadri impressionisti: trasla il significato, che riappare a una certa distanza.
E come in una delle ultime opere di Ai Weiwei, che ha ricostruito le ninfee di Monet con 650.000 mattoncini Lego. Praticamente, una supermetafora.
P.S.
Oggi un saltello a piè pari in stile Lego, addirittura alla domenica sera. Comunque, eccoci qua, e come sempre vi aggiungo anche il bottone da schiacciare per fare passaparola di Linguetta (e ricevere dei premi).
🖊️ Inversi
Oggi alcuni versi tratti dal libro Prima che sia notte di Silvia Vecchini (illustrazioni di Sualzo), in cui una ragazzina racconta la storia del fratello Carlo, che non sente, non vede da un occhio e rischia di non vedere anche dall’altro. La narrazione è un po’ in prosa e un po’ in versi. Ho scelto questi:
Fuoco e fiamme
neve e ghiaccio
leggo
leggo
leggo
taccio.
📚 Leggere intorno
Nella collana Biblioteca minima di Adelphi c’è un racconto d H.G. Wells che è un gioiello letterario, perché riesce a fare quello che solo la fantascienza può: spostare i confini, mutare la prospettiva. S’intitola Nel Paese dei Ciechi (traduzione di Franco Salvatorelli), e il protagonista è Nuñez, che un giorno arriva in una misteriosa vallata sulle Ande ecuadoriane, dove gli abitanti sentono i microfruscii a dieci chilometri di distanza, sanno orientarsi senza bisogno di mappe, vivono secondo il binomio caldo/freddo e non giorno/notte. Sono tutti senza occhi.
Il secondo e terzo consiglio sono per due albi illustrati, inni al potere della sinestesia:
Lucia di Roger Olmos, che racconta il tragitto di una bambina cieca da casa a scuola, rendendo visibili tutti i sensi.
Il libro nero dei colori di Menena Cottin e Rosaria Faría (traduzione di Fabian Negrin), che fa sentire i colori sotto le dita e si può leggere in caratteri braille.
🎥 Uccidere i fiori
Sono andato a vedere Killers of the Flower Moon, perché come si fa a rinunciare all’uscita di un film di Martin Scorsese? Del film s’è detto soprattutto della lunghezza (3h26’) e ammetto che mentre ero in sala ho sentito un po’ il peso della durata, che ad esempio non avvertii con Oppenheimer (3h), col penultimo scorsesiano The Irishman (3h29’), con l’amato C’era una volta in America (4h11’) o con altri film sopra le tre ore.
Ma il giorno dopo … be’ il giorno dopo si sente che quella lì era la misura giusta per dire e fare vedere le cose che sono successe ai nativi americani Osage. Soprattutto la durata necessaria perché la regia conquisti chi voglia impegnarsi a seguirla dentro una storia che — al netto dello smascellamento alla Marlon Brando di De Niro e DiCaprio — racconta il male umano, svelandolo un pezzetto alla volta.
🎧 Senti senti
L’immensa libreria digitale di Ad alta voce su RaiPlay Sound è lì pronta per essere ascoltata, con romanzi, racconti e poesie letti da grandi attrici e attori. Una risorsa pubblica da tenere sempre a portata di mano, o meglio d’orecchio.
🗞️ Pezzi da Post
Sul Post c’è Andare a teatro senza vedere o sentire, che racconta del programma di accessibilità del Teatro Stabile di Torino.
Sempre sul Post ho letto di una lingua icastica, cioè che ha nel suo statuto la potenzialità materica dell’immagine: il dialetto; anzi, i tanti dialetti che resistono. Ne ha scritto la traduttrice Stella Sacchini nel bel pezzo Il dialetto padrone del mondo, raccontando quel sostrato linguistico primordiale che ci dà forma, ci nomina e da cui solo allontanandoci possiamo (un po’) liberarci.
Mi sa che è tutto, noi ci leggiamo alla prossima Linguetta!
Figuriamoci il mondo pensando anche a chi non ha occhi per guardarlo, in fondo ci basta il 💖, lo stesso cuore che sta qui sotto e che potete pigiare per dirmi se v’è piaciuta la puntata.
Per lasciare un commento c’è lo spazio lì accanto, ma vi aspetto pure via mail, oppure dentro le Notes con un restack della puntata (cioè pigiando la rotellina con le due frecce accanto al simbolo dei commenti).
Se volete taggarmi su Instagram, cercatemi come andrjet.






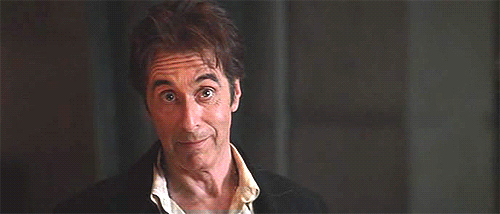








Che bello questo numero, mi ha acceso mille scintille. Il racconto di Wells lo ricordo come una rivelazione, mi aprì davvero gli occhi su tante cose.
In questi giorni un amico che fa l'accompagnatore turistico sta guidando un gruppo di non vedenti per la Grecia e ho scoperto che i siti archeologici più importanti di Atene ma anche Micene e Delfi hanno percorsi tattili che non avevo mai notato durante le mie visite. Davvero basta appena accorgersi degli altri perché si aprano altri mondi e altri modi di farne esperienza.